Ottimo mese, giugno, per le uscite discografiche. Anche questa volta elenco e illustro alcuni degli album più belli usciti nel sesto mese dell'anno. Molti esordi, un coraggioso tentativo di ridefinizione del sound e diversi artisti sacrificati (Os Mutantes, The Cars, The House of Love) sono gli ingredienti delle scelte di questa puntata. Come al solito, enjoy!
► 1968
Silver Apples - Silver Apples (Kapp)
L'elettronica, negli anni Sessanta, iniziava a travalicare l'ambito colto e sperimentale per contaminare i linguaggi pop: a partire dagli ambienti Spage Age Pop e dintorni (Perrey-Kingsley, Attilio Mineo, Esquivel, Joe Meek, per non parlare della musica per bambini di Raymond Scott), l'ondata psichedelica si dimostrava altrettanto disposta a far uso di sonorità electro per estendere la gamma di stramberie psichedeliche degli arrangiamenti (penso agli United States, ai Fifty Foot Hose, ai White Noise, a Mort Garson).
Nell'elenco, a questo punto, non possiamo non citare i Silver Apples, duo newyorkese formato da Simeon Coxe e Dan Taylor, che di composizioni ipnotiche a base di oscillatori (l'artigianale proto-sintetizzatore chiamato "The Simeon") e batteria fecero la loro specialità. Psichedelia, certo, ma interamente dedita a una formula densissima, seppur minimale, di droni elettronici e basi ritmiche ossessive, circolari, navigate da litanie stralunate spesso e volentieri subissate dal crescere delle masse sonore.
La parola d'ordine è ripetitività: la prima "Oscillations" è un fitto coacervo di suoni mai sentiti, o almeno non in tale guisa. Sibili e feedback elettronici fendono il pulsare del loop che costituisce la base del pezzo, mentre il pattern ritmico di Dan Taylor gioca sugli accenti rappresentando un fenomenale catalizzatore di intensità, sposandosi alla perfezione con il caos organizzato sprigionato da Coxe. Pochi, pochissimi elementi a screziare gli arrangiamenti: un flauto in "Seagreen Serenades", collage di frammenti concretisti (tra opera e frammenti radio e tv) in "Program", percussioni ossessive in "Dancing Gods". Per il resto ogni sforzo è profuso nell'incessante manipolazione delle isoipse con fuzz e filtri di ogni sorta, nell'accostamento di pochi spunti armonici a stranianti espedienti atonali e dissonanti (la bellissima "Misty Mountains"), nella creazione di coaguli di textures, di brani dove a uno svolgimento generalmente piano si oppone un microcosmo di variazioni di intensità, di screziature superficiali (le modulazioni di "Lovefingers"), di addensamento sonico (il rutilante accumulo di carica di "Velvet Cave").
Impossibile non pensare alla grande influenza dei Silver Apples sulla musica futura, dai Suicide ai Portishead, passando per il Krautrock e arrivando alla scena post-rock. Impossibile, dunque, non ricordare il primo album del duo newyorkese come uno degli esperimenti pop più impattanti di sempre.
► 1978
Magazine - Real Life (Virgin)
"Cercasi musicisti per eseguire e registrare musica veloce e lenta. Mentalità punk non essenziale". Questo, ci racconta Simon Reynolds, era l'annuncio con il quale Howard Devoto informava di star cercando musicisti per un nuovo progetto. A incuriosire, due fatti: il primo è che Devoto, con i suoi Buzzcocks, era stato tra i primi a sfruttare le potenzialità del punk; il secondo è che Devoto stesso fu tra i primi ad accorgersi della strada a senso unico imboccata da quel movimento, presto divenuto lo spauracchio di se stesso. Uscito dai Buzzcocks, dunque, Devoto era già pronto per il passo successivo, quello di abbracciare (e allo stesso tempo sconfessare) tutte le cross-categorie musicali ed estetiche della new wave, riportando la sua musica all'interno di un discorso dove non era necessario sputare su quanto fatto prima (il glam, addirittura il prog-rock!) per creare suoni nuovi e moderni (ispirati perlopiù al Bowie del periodo berlinese). Si ritornava, dunque, a scorrere nell'ideale alveo in progressivo sviluppo della storia del pop.
La musica dei Magazine era artistoide, affettata, ambientale, ricercata, cerebrale, in qualche modo anche classica (rock, insomma). All'uscita di "Real Life" il gruppo comprendeva il chitarrista John McGeogh (più tardi confluito nei Siouxsie and The Banshees), il bassista Barry Adamson, il tastierista (!) Dave Formula, il batterista Martin Jackson. Interessante notare, per capire la vocazione non punk della band, che tre dei membri del gruppo (Formula, McGeogh e Adamson) finirono nelle fila della band cardine della scena New Romantics, i Visage.
L'apertura dell'esordio è affidata ai suoni elettronici irraggianti di "Definitive Gaze", vicina alle sonorità tedesche di gruppi come Harmonia o Cluster filtrati da Brian Eno, dove il basso imita uno straniante giro funky/reggae (con tastiera spiritual sullo sfondo) e la chitarra produce un coacervo di riff contorti e graffianti, mentre Devoto snocciola lamentoso le sue liriche. Musica stratificata, strutturalmente ricca, avventurosa e innovativa: "My Tulpa" guarda rispettosamente a Iggy Pop e Roxy Music aggiungendo frenesia e nervosismo tipicamente post-punk, senza rinunciare ai fasti delle tastiere di Formula, mentre "Shot By Both Sides" erige un monumento rock di grande assertività, dominato dalla trascinante presenza scenica di Devoto e da una chitarra plasmante, capace di piegare il brano ad una solennità inedita (è McGeogh che impone il mood, che regola accenti e sfumature timbriche, lui che si lancia in impennate soliste coraggiosissime in tempi di rifiuto del rock tradizionale).
I percorsi seguiti sono ancora molti. La furia punk è incanalata in uno strutturante pulsare futuristico ("Recoil"), si coltivano momenti dark e ambientali colmi di eleganza decadente ("Burst" e "Motorcade", quest'ultima capace di passare da atmosfere pre-Joy Division a un contorto sviluppo in tutto e per tutto progressive), si passano in rassegna psichedelia da baraccone anni Sessanta ("The Great Beautician in the Sky") e glam magniloquente e drammatico ("The Light Pours Out of Me").
Un capolavoro che supera continuamente se stesso senza per questo rinnegare la sua appartenenza a una tradizione, di far parte di una storia. Imperdibile.
"Cercasi musicisti per eseguire e registrare musica veloce e lenta. Mentalità punk non essenziale". Questo, ci racconta Simon Reynolds, era l'annuncio con il quale Howard Devoto informava di star cercando musicisti per un nuovo progetto. A incuriosire, due fatti: il primo è che Devoto, con i suoi Buzzcocks, era stato tra i primi a sfruttare le potenzialità del punk; il secondo è che Devoto stesso fu tra i primi ad accorgersi della strada a senso unico imboccata da quel movimento, presto divenuto lo spauracchio di se stesso. Uscito dai Buzzcocks, dunque, Devoto era già pronto per il passo successivo, quello di abbracciare (e allo stesso tempo sconfessare) tutte le cross-categorie musicali ed estetiche della new wave, riportando la sua musica all'interno di un discorso dove non era necessario sputare su quanto fatto prima (il glam, addirittura il prog-rock!) per creare suoni nuovi e moderni (ispirati perlopiù al Bowie del periodo berlinese). Si ritornava, dunque, a scorrere nell'ideale alveo in progressivo sviluppo della storia del pop.
La musica dei Magazine era artistoide, affettata, ambientale, ricercata, cerebrale, in qualche modo anche classica (rock, insomma). All'uscita di "Real Life" il gruppo comprendeva il chitarrista John McGeogh (più tardi confluito nei Siouxsie and The Banshees), il bassista Barry Adamson, il tastierista (!) Dave Formula, il batterista Martin Jackson. Interessante notare, per capire la vocazione non punk della band, che tre dei membri del gruppo (Formula, McGeogh e Adamson) finirono nelle fila della band cardine della scena New Romantics, i Visage.
L'apertura dell'esordio è affidata ai suoni elettronici irraggianti di "Definitive Gaze", vicina alle sonorità tedesche di gruppi come Harmonia o Cluster filtrati da Brian Eno, dove il basso imita uno straniante giro funky/reggae (con tastiera spiritual sullo sfondo) e la chitarra produce un coacervo di riff contorti e graffianti, mentre Devoto snocciola lamentoso le sue liriche. Musica stratificata, strutturalmente ricca, avventurosa e innovativa: "My Tulpa" guarda rispettosamente a Iggy Pop e Roxy Music aggiungendo frenesia e nervosismo tipicamente post-punk, senza rinunciare ai fasti delle tastiere di Formula, mentre "Shot By Both Sides" erige un monumento rock di grande assertività, dominato dalla trascinante presenza scenica di Devoto e da una chitarra plasmante, capace di piegare il brano ad una solennità inedita (è McGeogh che impone il mood, che regola accenti e sfumature timbriche, lui che si lancia in impennate soliste coraggiosissime in tempi di rifiuto del rock tradizionale).
I percorsi seguiti sono ancora molti. La furia punk è incanalata in uno strutturante pulsare futuristico ("Recoil"), si coltivano momenti dark e ambientali colmi di eleganza decadente ("Burst" e "Motorcade", quest'ultima capace di passare da atmosfere pre-Joy Division a un contorto sviluppo in tutto e per tutto progressive), si passano in rassegna psichedelia da baraccone anni Sessanta ("The Great Beautician in the Sky") e glam magniloquente e drammatico ("The Light Pours Out of Me").
Un capolavoro che supera continuamente se stesso senza per questo rinnegare la sua appartenenza a una tradizione, di far parte di una storia. Imperdibile.
► 1988
A.R. Kane - 69 (Rough Trade)
Il roster della Rough Trade anni Ottanta è uno scrigno delle meraviglie: tutti i principali sommovimenti della scena indie britannica sono rappresentati, dal post-punk al jangle, dal dream pop all'industrial, con nomi come Cabaret Voltaire, Fall, Smiths, Pixies, Galaxie 500 e molti altri. La presenza dei londinesi A.R. Kane in un tale repertorio è quindi tanto naturale quanto spiazzante: da un lato, infatti, la loro musica era un tentativo estremo di fagocitare stili plurimi, dall'altra però risultava una certa estraneità dal mondo rappresentato dalla Rough Trade. Alex Ayuli e Rudy Tambala erano neri, si ispiravano a Miles Davis, al jazz, al dub, alla musica soul. Eppure quelle chitarre aeree e sfibrate, l'uso di effetti e di rumore, fa pensare a un contatto con la scena alternativa di Cocteau Twins, Jesus and Mary Chain e My Bloody Valentine. Insomma: una matassa difficile da sbrogliare, ma interessatissima da ascoltare.
In realtà "69" ha più a che fare con il futuro che con il passato. Nel 1988 un disco del genere doveva sembrare indecifrabile proprio perché era troppo avanti, parlava linguaggi alieni, in grado di apparire tali ancora oggi. Ottimo motivo per non farsi scappare gli A.R. Kane. La prima "Crazy Blue" è un rutilante manifesto del sound del duo: un'instancabile linea di basso fornisce una netta traccia di scorrimento a vocalizzi espansi e a un universo sonoro ubriacante fatto di accordi riverberatissimi di chitarra, tappeti percussivi, il tutto intrecciato in un'armonia complessiva irraggiante, un mix tra indie pop scanzonato (gli accordi stoppati della chitarra solista), raffinatezze arty alla Prefab Sprout e Talk Talk, anticipazioni di post-rock e slowcore (la splendida "The Madonna Is With Child") e inedita sperimentazione di timbri e risonanze ("Sulliday", "The Sun Falls Into the Sea").
Il livello di astrazione sonora raggiunge livelli altissimi: si prenda l'informe "Suicide Kiss", immersa in scariche di distorsioni elettriche che disintegrano progressivamente ogni riconoscibilità melodica, o la dub contaminatissima di "Baby Milk Snatcher", o ancora la musica da camera destrutturata di "Dizzy" e il viaggio psichedelico rarefatto e irraggiante di "Spermwhale Trip Over".
Un lavoro incredibile, capace di una carica immaginifica inedita, ancora oggi spiazzante. Avanguardia pop ai massimi livelli.
Il roster della Rough Trade anni Ottanta è uno scrigno delle meraviglie: tutti i principali sommovimenti della scena indie britannica sono rappresentati, dal post-punk al jangle, dal dream pop all'industrial, con nomi come Cabaret Voltaire, Fall, Smiths, Pixies, Galaxie 500 e molti altri. La presenza dei londinesi A.R. Kane in un tale repertorio è quindi tanto naturale quanto spiazzante: da un lato, infatti, la loro musica era un tentativo estremo di fagocitare stili plurimi, dall'altra però risultava una certa estraneità dal mondo rappresentato dalla Rough Trade. Alex Ayuli e Rudy Tambala erano neri, si ispiravano a Miles Davis, al jazz, al dub, alla musica soul. Eppure quelle chitarre aeree e sfibrate, l'uso di effetti e di rumore, fa pensare a un contatto con la scena alternativa di Cocteau Twins, Jesus and Mary Chain e My Bloody Valentine. Insomma: una matassa difficile da sbrogliare, ma interessatissima da ascoltare.
In realtà "69" ha più a che fare con il futuro che con il passato. Nel 1988 un disco del genere doveva sembrare indecifrabile proprio perché era troppo avanti, parlava linguaggi alieni, in grado di apparire tali ancora oggi. Ottimo motivo per non farsi scappare gli A.R. Kane. La prima "Crazy Blue" è un rutilante manifesto del sound del duo: un'instancabile linea di basso fornisce una netta traccia di scorrimento a vocalizzi espansi e a un universo sonoro ubriacante fatto di accordi riverberatissimi di chitarra, tappeti percussivi, il tutto intrecciato in un'armonia complessiva irraggiante, un mix tra indie pop scanzonato (gli accordi stoppati della chitarra solista), raffinatezze arty alla Prefab Sprout e Talk Talk, anticipazioni di post-rock e slowcore (la splendida "The Madonna Is With Child") e inedita sperimentazione di timbri e risonanze ("Sulliday", "The Sun Falls Into the Sea").
Il livello di astrazione sonora raggiunge livelli altissimi: si prenda l'informe "Suicide Kiss", immersa in scariche di distorsioni elettriche che disintegrano progressivamente ogni riconoscibilità melodica, o la dub contaminatissima di "Baby Milk Snatcher", o ancora la musica da camera destrutturata di "Dizzy" e il viaggio psichedelico rarefatto e irraggiante di "Spermwhale Trip Over".
Un lavoro incredibile, capace di una carica immaginifica inedita, ancora oggi spiazzante. Avanguardia pop ai massimi livelli.
► 1998
The Smashing Pumpkins - Adore (Hut)
È luogo comune considerare il quarto album dei Pumpkins l'inizio della loro rovina. Licenziato il batterista Chamberlin, perso il tastierista turnista Jonathan Melvoin (morto per overdose durante il tour di "Mellon Collie and The Infinite Sadness"), la band è ormai l'indiscussa creatura del frontman Billy Corgan, non scevro da problemi personali (un divorzio e la morte della madre), mentre James Iha e D'arcy Wretzky sono appena citati nei credits. Corgan lavora all'album in solitudine, passando ore in studio di registrazione, riducendo al minimo l'apporto del produttore Brad Wood e attorniandosi di gente fidata (Flood al mixaggio e Bon Harris all'elettronica), adatta per plasmare la sua visione di come i Pumpkins dovessero suonare nel 1998.
Il risultato è un lavoro notturno, ambientale, con meno chitarre e rumore, più pianoforte, elettronica e lavoro sulle tessiture, per una versione amplificata e gotica (si prenda "Pug") dei toni vampireschi della band. Nonostante un buon successo commerciale "Adore" ha sempre risentito di una reputazione controversa, ambigua, vuoi per la lunghezza, vuoi per il netto cambio di registro. Eppure ho sempre considerato l'album come l'altra, perfetta, faccia della medaglia Smashing Pumpkins: un concentrato della poetica ombrosa e lugubre di Corgan, unita alla maestria nel generare melodie sontuose e drammatiche.
I brani memorabili sono tanti (penso alla prima elegantissima "To Sheila", a "Perfect", "Tear", "Shame"), ma è l'atmosfera complessiva a risultare tanto affascinante, a legare i singoli brani in un abbraccio di gelido romanticismo oscuro (i rintocchi echeggianti di pianoforte in "Blank Page", spolverata da strati eterei di elettronica). Il trentunenne Corgan trova modo per dare respiro alla sua grande verve melodica, alle sue armonie gravi e tormentate, alla sua poetica che qui fa i conti con una rassegnata maturità (parlando della sua vita al passato remoto: "Once upon a time in my life / I went falling", canta in "Once Upon a Time"), dando forma a spazi dilatati, sommessi, sempre nella penombra di un permeante senso del tragico.
Un lavoro che richiede tempo per essere assorbito e apprezzato a dovere. E a uno come Corgan un po' di tempo non si può certo negare.
È luogo comune considerare il quarto album dei Pumpkins l'inizio della loro rovina. Licenziato il batterista Chamberlin, perso il tastierista turnista Jonathan Melvoin (morto per overdose durante il tour di "Mellon Collie and The Infinite Sadness"), la band è ormai l'indiscussa creatura del frontman Billy Corgan, non scevro da problemi personali (un divorzio e la morte della madre), mentre James Iha e D'arcy Wretzky sono appena citati nei credits. Corgan lavora all'album in solitudine, passando ore in studio di registrazione, riducendo al minimo l'apporto del produttore Brad Wood e attorniandosi di gente fidata (Flood al mixaggio e Bon Harris all'elettronica), adatta per plasmare la sua visione di come i Pumpkins dovessero suonare nel 1998.
Il risultato è un lavoro notturno, ambientale, con meno chitarre e rumore, più pianoforte, elettronica e lavoro sulle tessiture, per una versione amplificata e gotica (si prenda "Pug") dei toni vampireschi della band. Nonostante un buon successo commerciale "Adore" ha sempre risentito di una reputazione controversa, ambigua, vuoi per la lunghezza, vuoi per il netto cambio di registro. Eppure ho sempre considerato l'album come l'altra, perfetta, faccia della medaglia Smashing Pumpkins: un concentrato della poetica ombrosa e lugubre di Corgan, unita alla maestria nel generare melodie sontuose e drammatiche.
I brani memorabili sono tanti (penso alla prima elegantissima "To Sheila", a "Perfect", "Tear", "Shame"), ma è l'atmosfera complessiva a risultare tanto affascinante, a legare i singoli brani in un abbraccio di gelido romanticismo oscuro (i rintocchi echeggianti di pianoforte in "Blank Page", spolverata da strati eterei di elettronica). Il trentunenne Corgan trova modo per dare respiro alla sua grande verve melodica, alle sue armonie gravi e tormentate, alla sua poetica che qui fa i conti con una rassegnata maturità (parlando della sua vita al passato remoto: "Once upon a time in my life / I went falling", canta in "Once Upon a Time"), dando forma a spazi dilatati, sommessi, sempre nella penombra di un permeante senso del tragico.
Un lavoro che richiede tempo per essere assorbito e apprezzato a dovere. E a uno come Corgan un po' di tempo non si può certo negare.
► 2008
L'esordio dei Fleet Foxes rappresenta uno dei casi eclatanti del 2008, un anno piuttosto movimentato, in ambito pop. I gruppi di barbudos armati di chitarre acustiche e spirito fricchettone non erano certo una novità, ma la formula, in questo caso, fa leva su elementi inediti, su una coralità che pesca dai sessanta-settanta americani (CSN&Y), da un recupero di stilemi americana che vanno dal folk degli Appalachi al recupero di sonorità nettamente british, legando il tutto con un'interpretazione classica, da menestrelli d'altri tempi, e una freschezza melodica invidiabile.
A sentirlo oggi, il lavoro conserva ancora il fascino di un esordio genuino, capace di dar vita a una visione personalissima, azzeccando l'equilibrio tra autenticità espressiva e artificio artistico, rievocazione rétro e rielaborazione coscientemente attuale. E così la tracklist dell'album è una piacevolissima tavolozza policromatica dove si rincorrono brani come lo spiritual "Sun It Rises", tra echi di Brian Wilson, assaggi di banjo in stile folk tradizionale e assolo psichedelico alla Byrds, bozzetti corali del calibro della pastorale "White Winter Hymnal", il country solare e spigliato di "Ragged Wood", la ballata english folk "Tiger Mountain Peasant Song", il jangle anni Sessanta di "Quiet Houses", i vocalizzi eterei che ricordano il Crosby del '71 della strumentale "Heard Them Stirring" e le incantevoli trame acustiche di "Meadowlarks" e "Oliver James".
Un album che ha retto benissimo la prova del tempo, confermando in pieno il suo valore.
A sentirlo oggi, il lavoro conserva ancora il fascino di un esordio genuino, capace di dar vita a una visione personalissima, azzeccando l'equilibrio tra autenticità espressiva e artificio artistico, rievocazione rétro e rielaborazione coscientemente attuale. E così la tracklist dell'album è una piacevolissima tavolozza policromatica dove si rincorrono brani come lo spiritual "Sun It Rises", tra echi di Brian Wilson, assaggi di banjo in stile folk tradizionale e assolo psichedelico alla Byrds, bozzetti corali del calibro della pastorale "White Winter Hymnal", il country solare e spigliato di "Ragged Wood", la ballata english folk "Tiger Mountain Peasant Song", il jangle anni Sessanta di "Quiet Houses", i vocalizzi eterei che ricordano il Crosby del '71 della strumentale "Heard Them Stirring" e le incantevoli trame acustiche di "Meadowlarks" e "Oliver James".
Un album che ha retto benissimo la prova del tempo, confermando in pieno il suo valore.

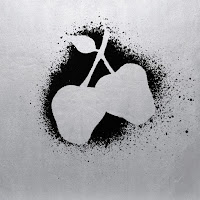




0 commenti:
Posta un commento
Commenta e dimmi la tua. Grazie!